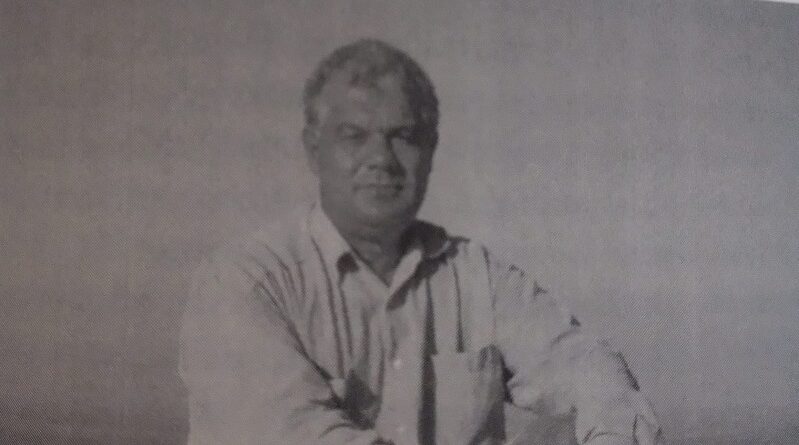Il dialetto calabrese: un tesoro linguistico-antropologico svelato
Lettura linguistico-antropologica attraverso il libro di Mario Emilio Griffo Canti e proverbi Calabresi – Maierato e dintorni
Analisi linguistica antropologica di Pino Cinquegrana
Nei tempi mitologici furono poeti popolari: il dio Pane, Anfione, Lino e Orfeo.
(E. Rubbieri, 1877:3)
A voi fieri Calabresi che accoglieste ospitali me straniero nelle ricerche e indagini infaticabilmente cooperando alla raccolta di questi materiali, dedico questo libro che chiude nelle pagine il tesoro di vita del vostro nobile linguaggio.
— Gerhard Rohlfs
La Calabria ha una ricca tradizione orale fatta di canti popolari, proverbi, detti, indovinelli, formule magiche, cunti e filastrocche, tramandati di generazione in generazione. Questi esprimono la saggezza contadina, il legame con la terra, la religiosità, l’amore, il dolore e la resilienza di un popolo forte.
Un mosaico linguistico estremamente variegato, frutto di secoli di influenze storiche (greche, latine, arabe, normanne, ebraiche, spagnole, occitaniche francesi) e della geografia dei luoghi che rende alcune parlate enclave linguistico-culturale.
Pertanto, parlare del dialetto calabrese richiede la giusta identificazione dell’area geografica di riferimento:
-
Settentrionale (provincia di Cosenza – soprattutto nord, parte di Catanzaro, con influenza linguistica napoletana)
-
Calabrese centrale (area centrale di Catanzaro, Vibo Valentia, influenza tra napoletano e siciliano)
-
Calabrese meridionale (zone di Reggio Calabria, Locride, parte di Vibo, con forte influenza siciliana)
Fatta questa breve premessa, si può sottolineare che l’opera Canti e Proverbi Calabresi – Maierato e dintorni di Mario Griffo completa e risponde alle esigenze paremiologiche e paremiografiche di Maierato, che ha visto autori diversi impegnati su questo interesse comunicativo-relazionale:
Dal Generale Domenico Reale al Direttore Didattico Domenico Burello, dal professore Joseph Vittorio Greco al Professore Giuseppe Greco, da Giuseppe (Pino Cinquegrana) a Domenico (Mimmo) Rizzo.
Autori che rispondono attraverso i propri studi allo studio di Ermolao Rubieri, scrittore e poeta del XIX secolo, il quale sottolinea che il verso dialettale va letto secondo tre indicazioni:
-
Scritti non dal popolo ma per il popolo
-
Scritti dal popolo per il popolo
-
Scritti non dal popolo ma adottati dal popolo
Giuseppe Pitré, Raffaele Lombardi Satriani, Giuseppe Chiapparo e altri hanno individuato nella parlata popolare l’anima e lo spirito di ogni segmento della vita contadina: dal corteggiamento alla festa religiosa, dal lavoro al cibo, dalla magia alla tradizione giuridico-popolare. Questo secondo il pensiero del sociologo, antropologo e filosofo Albert Camus.
Marco Tullio Cicerone scriveva:
“L’humanitas si forma accogliendo l’eredità di sapienza tramandataci dagli antichi… è cultura anche la tradizione, il proverbio, il canto popolare così ricco di sentimenti e di valori… patrimonio che arricchisce la nostra humanitas.”
E Niccolò Tommaseo aggiunge:
“Se tutti i proverbi di ogni popolo si potessero raccogliere e ordinare… con le varianti di voci, d’immagini, di concetti, questo dopo la Bibbia sarebbe il libro più gravido di pensieri.”
Strambotti, serenate e mattinate diventano scelte linguistiche che il cantore rende nei versi, nel bene e nel male, per la propria donna.
Esempio di canto popolare:
Affaccia bella mia pemmu ti viju (pag. 7)
Analisi del contenuto:
-
Tema centrale: amore struggente e attesa; il poeta si rivolge alla donna amata, desiderando vederla almeno affacciarsi.
-
Tono e stile: appassionato, diretto, quasi disperato; il dialetto trasmette emozioni profonde e autentiche.
-
Struttura e metrica: quattro versi senza rima obbligata, ritmo naturale tipico dei canti popolari del Sud. L’enjambement accentua la continuità del pensiero e l’urgenza emotiva.
Analisi linguistica e retorica:
-
Affaccia bella mia: apostrofe amorosa, richiesta diretta, supplica
-
P’emu ti viju: desiderio immediato di vedere la persona amata
-
Eu pe l’amuri toi cc’avanzi staju: il poeta è fermo davanti alla casa dell’amata, spinto dall’amore
-
Si staju n’atra ura e no ti viju / rimingu pe lu mundu mi ndi vaju: dolore e sconfitta, amore non ricambiato, fuga volontaria simile a figura del viandante
Proverbio: Cu a luna i Jennaru nterra vidi o toi dinaru (pag. 69)
-
Interpretazione simbolica:
-
Luna di gennaio: freddo, riflessione, riposo dei campi, previsione agricola
-
Vedi il tuo denaro per terra: spreco, perdita, cattiva sorte
-
-
Significato complessivo: chi agisce azzardando a gennaio rischia di perdere i propri soldi.
-
Contesto culturale e agricolo: gennaio è mese di attesa; il proverbio invita alla prudenza, non fidarsi delle apparenze, evitare decisioni affrettate.
Conclusione:
Il proverbio calabrese Cu a luna i Jennaru nterra vidi o toi dinaru è un monito tradizionale che ricorda la saggezza contadina: la luna, bella ma ingannevole, non deve guidare le azioni concrete; altrimenti si rischia di “vedere il proprio denaro a terra”, ossia di perderlo.